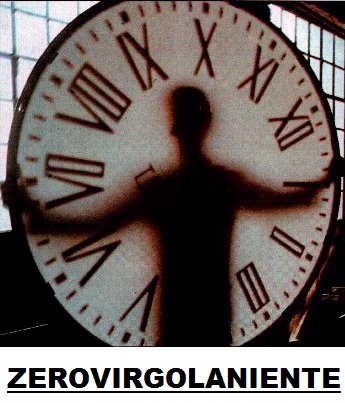Una company o un laboratorio di sperimentazione sociale?
Nell'androne, in mezzo a mucchi di immondizia, alcuni bambini giocavano con i loro miniesemplari di equus. Erano tra i più fortunati: di solito questi giocattoli (imitazioni
ben riuscite degli ippoandroidi in dotazione all'esercito) potevano permetterseli in pochi, dato che costavano un occhio della testa.
Uno dei ragazzini aveva con sé un piccolo cane che, nel vedermi, abbaiò selvaggiamente.
Mi chinai sul pulcioso dicendo: «Sai solo abbaiare, cagnolino? Non mordi mai?»
«Attento che morde pure!» esclamò il moccioso, che era affetto da strabismo.
Lo osservai inarcando le sopracciglia. Conoscevo suo padre: nel suo appartamento allevava cani, e anche gatti, che faceva ingrassare prima di spacciarli come prelibatezze. Erano prelibatezze. Io stesso avevo mangiato di quella carne sotto gli occhi inorriditi di Allen, che era un vegetariano della prima ora, e potevo dunque testimoniarne la bontà.
«Non puoi giocare come gli altri, eh?» dissi al piccolo strabico.
«Si chiama Bello», si limitò a dire lui, trattenendo il cane che, ora ringhiando, avrebbe voluto avventarmisi contro, attentando alla salute dei miei calzoni.
«O-oh», feci, sgusciando via. «Scommetto che non ha nemmeno un pedigree.»
Guercino mi guardò senza capire.
«Un albero genealogico. Una famiglia. Non ce l'ha.»
«Oh sì, invece», mi contraddisse, mentre io ero già sul portone. «La mamma di Bello si chiama Momo, i fratelli Ingo e Immo. Il papà, Dracula,
è morto lo scorso dicembre.»
«Morto cucinato», lanciai da dietro le mie spalle.
La strada pullulava di gente: l'armata dei senzalavoro. Non si può dire però che fossero sfaccendati. Da quando il governo non elargiva più il sussidio di
sopravvivenza, i cittadini si dedicavano a molteplici traffici. Chi non si ingegnava, chi non aveva nulla da vendere, nemmeno i propri organi, finiva indigente, a morire sotto un ponte o un cavalcavia.
A me serviva urgentemente un lavoro. Non che temessi di trapassare in uno degli ormai numerosi "cimiteri dei morti di fame", come li chiamavano: finché Allen godeva
di ottima salute, sarei potuto rimanere al sicuro con lui. Era soprattutto per ricaricare la mia Moneycard. Senza crediti a sufficienza, ci si sente più vulnerabili, a parte che la vita non è vita.
Era una bella mattina primaverile e fu perciò un piacere attraversare a piedi l'intera città. Era ancora troppo presto per imbattersi in qualche criminale prezzolato
o in desperados armati di clava o coltello: la feccia più spietata sarebbe uscita solo con il calare delle tenebre, come gli scarafaggi.
Dopo aver ammirato per un po' il frontespizio del palazzo su cui capeggiavano le lettere "K.E.", spinsi la porta ad aria compressa e puntai sulla ragazza al desk. Lei
mi indicò l'ascensore dicendomi a che piano dovevo salire. Intanto un guardiano in uniforme, con il distintivo della corporazione e il revolver bene in vista, stava a scrutarmi da rispettosa distanza.
Sbucai dall'ascensore in un corridoio pieno di lampade fluorescenti che diffondevano una luce biancastra. L'ufficio del researcher era a sinistra. Picchiai sulla porta ed
entrai.
L'uomo aveva una testa a forma di proiettile e la voce rauca, come se un acido gli avesse corroso le corde vocali. Dopo i preliminari, mi pose alcune domande all'apparenza
innocue ma che in realtà - come ben sapevo - erano parte integrante della prova attitudinale. Poiché non avevo nulla da perdere, risposi inalberando una buona dose di affabilità. A un dato punto lui scattò
in avanti (parve quasi che la sua testa-proiettile fosse stata sparata da un cannone) e si alzò. Vidi che teneva qualcosa in mano: un mini-recorder. Notando la mia espressione irretita, mi spiegò: «È
per i nostri archivi, sa». Poi mi mostrò alcuni grafici, parlando a ruota libera. Io guardai quelle proiezioni di disegni euclidei dicendo di sì senza capire un accidente. Infine venni mandato al controllo
medico, dove non fecero altro che prelevarmi un po' di sangue.
Quando mi riconvocarono, un'ora dopo, mi stupii di sentire il researcher esclamare: «Congratulazioni, signor Ferroni! Il posto è suo». A conferma di quelle
parole premette un bottone, e nel mio cranio le campane di una chiesa si misero a suonare a festa.
Fece il suo ingresso una venere bionda. «Questa è Marilinda», annunciò l'uomo. «Da oggi sarà la sua segretaria personale.»
Ero stordito, titubante. In fondo si trattava del primo colloquio di selezione che superavo... e già mi assegnavano la segretaria! La mia perplessità era dunque giustificabile.
Nondimeno, fu con delizia che mi posi sulla scia di quella sventola di ragazza. Prendemmo l'ascensore, che già odorava di essenze ma che subito si impregnò del profumo - certamente costoso - di Marilinda,
poi percorremmo lunghi corridoi rivestiti di coni fonoassorbenti, finché lei non si arrestò davanti a una porta.
Si chinò sul display e digitò la chiave d'accesso. Quindi mi lasciò il passo.
Era un ufficio ampio, dai vetri fumé e con una scrivania nuova fiammante. "Però!" pensai. "Niente male." Già: niente male per uno del mio
stampo, per uno come Pat Ferroni, che per anni aveva mendicato un posto di lavoro qualsiasi e che non poteva certo vantare referenze attendibili.
La segretaria poggiò sulla scrivania due cartelle, dicendomi che vi avrei trovato tutte le informazioni che mi occorrevano. Dopo mi dedicò un sorriso smagliante e concluse:
«Per qualsiasi cosa, mi chiami all'interfono».
«Senz'altro. Grazie, Marilinda.»
Aprii la prima cartella, su cui spiccava la scritta "Business Portfolio". Era piena di cifre e istogrammi che io non comprendevo e che forse mai avrei compreso. Passai
alla successiva, quella dei "First steps per i nuovi impiegati - Fase Uno". Lessi:
"For any organization, large or small, communicating is important to being effective. Frequent communications with customers, employees, investors,
or partners is a key driver to success".
Il testo parlava inoltre di "partecipazioni della Kosmos Enterprise a vari settori pubblici", di "proventi autoriproducentisi", di "Corporate Identity"
e roba del genere. Scoppiai a ridere. Era tutto fumo, aria calda: non mi aiutava a capire nulla sulla natura dell'azienda, né quel che pretendevano da me.
Per gioco, e anche per fare una specie di prova tecnica, chiamai la bionda all'interfono.
«Sì?»
Non sapendo che cosa dirle, le domandai: «Di regola a che ora è fissata la fine della giornata lavorativa?»
«Alle quindici, signor Ferroni.»
La ringraziai e chiusi la comunicazione. Mi misi a occhieggiare in giro. L'ufficio era provvisto di tivù via cavo, computer e (eureka!) frigobar. A quest'ultimo sottrassi
una bottiglia di Southern Comfort e, dopo essermene versato una generosa porzione, andai a sbirciare dentro un armadietto dall'aria misteriosa. Conteneva fruste, vibromassaggiatori e una bambola trisessuale di silicone.
Annuii compiaciuto: in quella prigione di lusso c'era tutto l'occorrente per ammazzare il tempo senza annoiarsi. Dentro un cassettone scoprii un assortimento di giochi per PC recanti il marchio della Macrohard (una
delle ditte che facevano capo alla K.E.). Ne testai alcuni con una mano sul mouseStick e l'altra stretta intorno al collo della bottiglia. I giochi strategici erano naturalmente per gli impiegati raziocinanti, mentre quelli
d'azione erano destinati ai tipi come me, agli impulsivi, agli impazienti. Guidai un carro armato, poi un'astronave, e in ultimo mi lasciai catturare dal fascino di Doom XII, dove ero un soldato dentro un labirinto pieno di mostri e ragni cibernetici che dovevo abbattere prima che loro mi trasformassero in un guscio umano grondante sangue. Riuscii
a raggiungere il terzo livello, dove deflagrai con un lugubre botto che colorò di rosso il monitor. Sempre abbracciato alla bottiglia, mi staccai dal computer e sprofondai
in una poltrona di pelle. Accesi la tele e scanalai per un'ora o due. L'apparecchio era programmato per ricevere unicamente film - film per ragazzi, d'avventura, d'animazione, commedie, thriller, hard porn,
ecc. Mi dissi: "Logico. Hollywood è un enorme mercato allucinogeno. Proprio quel che occorre al manager stressato".
Tornai a perlustrare l'armadio. C'era, in fondo a uno scaffale, una videocassetta. Si trattava di un supporto ormai antiquato, la cui vista mi spinse
al sorriso ma anche a inarcare interrogativamente le sopracciglia. Era senza copertina né etichetta. Tentennante, la rigirai tra le mani. Nell'ufficio non era presente nessun videoplayer (ne esistevano ancora? L'ultima
volta che ne avevo visto uno era stato nell'èra giurassica...). Mi strinsi nelle spalle e riposi la videocassetta sullo scaffale, dicendomi che forse era stata dimenticata lì dal mio predecessore.
Guardai ancora un po' di tivù, prendendo definitivamente confidenza con il telecomando, e infine me ne stetti del tutto inoperoso a osservare dalla finestra il traffico
sottostante come attraverso un cannocchiale capovolto. Il Southern Comfort si esaurì e, quando girai il polso per leggere l'orologio, scoprii che mancavano cinque minuti alle tre. Il mio primo giorno di lavoro si
era concluso brillantemente. Uscii barcollante dalla mia gabbia dorata e salutai Marilinda. Lei mi rivolse un sorriso a trentadue denti, flautando: «A domani, capo».
(CONTINUA)
(CONTINUA)
Transits su Amazon: Link eBook Kindle ( Amazon )
Link eBook Kindle ( Amazon )